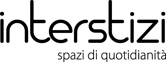07 - Città, bellezza e spazio pubblico: la sfida
28 giugno 2025

Nata nel 1991, Ingegnere Edile-Architetto con esperienze accademiche in progettazione partecipata e mediazione con l’amministrazione pubblica, continua ad aggiornarsi sulla frontiera dell’urbanistica.
Nell’Associazione Interstizi, di cui è fondatrice, si occupa di ricerca e pianificazione urbana partecipata.
[Premessa: Ciò che è scritto rappresenta una riflessione personale, frutto di un percorso di formazione nel campo dell’urbanistica e della partecipazione. Il tema è lo spazio pubblico. L’intento è quello di aprire un dibattito e una discussione sul modello di città a cui si aspira, di cui si parla troppo poco. Alcuni contenuti sono tratti dalla mia tesi di Master in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi, dal titolo “Società e spazio pubblico tra funzionalismo e complessità”, Relatore Mariano Sartore, Correlatrice Chiara Mazzoleni]
Tutto il ragionamento fatto nelle “puntate” precedenti dove vuole andare a parare?
Ecco un elenco di punti che mettono insieme alcune delle considerazioni fatte, mescolando aspetti tecnici e sociali, tra loro interconnessi:
- Si è voluto dimostrare quanto l’urbanistica non sia una materia che riguarda soltanto gli uffici tecnici o solo gli spazi, ma che ha molto a che fare con il pubblico, l’economia, il sociale. Si è voluto ricordare quanto essa dovrebbe tornare ad essere strumento di governo della città e del territorio.
- L’idea di città non si può improvvisare, ma è un processo complesso e durevole. Si deve avere un piano e poi un progetto da attuare nel tempo. L’amministrazione coraggiosa è quella che ha uno sguardo di lunga durata, senza la fretta di dover avere risultati nel breve tempo con l’unico fine di legittimare la propria campagna elettorale.
- Lo spazio pubblico dovrebbe tornare ad essere oggetto di progettualità. Esso non può essere relegato a spazio di passaggio, ma va pensato come luogo di permanenza.
- Preso atto della complessità del reale, l’approccio ha tanto più successo quanto più è multidisciplinare, perché capace di cogliere più sfaccettature possibili del “problema”.
- Per ogni problema, come diceva il prof Sartore, non esiste la bacchetta magica! Si deve agire su più fronti contemporaneamente, con un insieme di strategie che agiscono in maniera sinergica e flessibili, cioè aperte alla possibilità di “correggere il tiro” nel tempo.
- La questione non è ordinare il disordine, né riprodurlo formalmente, ma, come affermava De Carlo, porre le condizioni perché esso possa avere spazio di manifestarsi1. In altre parole, lo spazio pubblico deve essere pensato per ospitare funzioni diverse e non predefinite. Ciò permette di accogliere utenti diversi e differenti attività.
- Il progetto urbanistico, per rispondere alle attuali questioni urbane, deve tornare a considerare la sfera sociale come elemento di base del progetto, considerando la società nel suo territorio e reduce da una propria storia.
- Il progetto dello spazio pubblico è un’opportunità per recuperare la dimensione comunitaria, come luogo di aggregazione e come condivisione delle intenzionalità progettuali. Perché “lo spazio è spazio di pratiche, di relazioni, di corpi, anche nella fase del capitalismo impaziente”2.
- La prospettiva con cui si deve costruire il progetto della città deve essere il benessere dei suoi cittadini, utilizzando sempre il criterio della bellezza. Da ciò ne viene la responsabilità di una testimonianza culturale: la storia della nostra civiltà europea ce lo dimostra.
- C’è uno stretto legame tra la capacità critica e riconoscimento della bellezza. Il processo educativo fornisce gli strumenti fondamentali per una “rinascita culturale”, per tornare ad essere davvero cittadini.
- Serve immaginare un sistema diffuso/rete di spazi pubblici, permeabile, continuo — fatto di piazze, parchi, giardini e strade — che tenga insieme il tessuto urbano e quello sociale.
- L’automobile ha occupato molti dei nostri spazi pubblici (strade, piazze). Ciò a causa del nostro stile di vita, che velocemente ci ha portato ad accorciare i tempi, ma anche per la separazione delle funzioni urbane: cioè abitare in un luogo, lavorare in un altro, trascorrere il tempo libero in un altro ancora.
In un contesto di dispersione insediativa, avere un’auto a testa è indispensabile per fare qualsiasi cosa, lasciando il proprio paese più volte al giorno. I piccoli centri urbani sono sempre più privi di servizi ed i loro abitanti sono costretti a vivere le proprie frazioni come “dormitori”. Se si riducesse la necessità di spostamenti, diminuirebbero forse anche le automobili. Esiste una strategia politica possibile per incentivare ciò?
- Le piazze di molte nostre frazioni sono state sostituite da parcheggi, cosa che spesso ci sembra un traguardo di comodità, dimenticandoci quanto quegli spazi fossero importanti un tempo per le nostre comunità. Si dovrebbero restituire gli spazi pubblici (veramente pubblici, non pubblici ad uso privato) alle frazioni o immaginarne di nuovi. I criteri di base della loro progettazione dovrebbero essere la polifunzionalità, l’accessibilità, la permeabilità (intesa come possibilità di spostarsi da uno spazio pubblico all’altro senza interruzioni).
- C’è bisogno di un piano della mobilità serio. Come diceva Jane Jacobs, la frequentazione delle strade è indice di sicurezza e opportunità di socialità. Inoltre, più le strade risultano interessanti, per la qualità dello spazio e la ricchezza di vita, più esse saranno frequentate.
- C’è bisogno di un ripensamento e potenziamento della mobilità pubblica, studiando un sistema multimodale (cioè con l’uso combinato di più mezzi di trasporto per compiere uno spostamento) che massimizzi le possibilità di uso del mezzo pubblico, ma SOLO contestualmente allo studio di una rete di viabilità lenta, che possa rendere lo spostamento lento un’alternativa possibile e completa.
- La fase che precede la progettazione dello spazio (il processo di costruzione della conoscenza) è essa stessa occasione sociale di costruzione condivisa del bene comune. Da qui si rende indispensabile l’uso di pratiche partecipative (Ah, la partecipazione! Una delle parole più abusate del momento!), per le quali non si intende una raccolta di opinioni tramite post-it, ma un processo complesso e spesso conflittuale, di una certa durata nel tempo, che coinvolge i tre tipi di conoscenza (esperto/sapere tecnico, decisore pubblico, cittadinanza/sapere diffuso), libero e aperto, finalizzato alla costruzione competente di un progetto URBANISTICO veramente condiviso ed efficace.
Esperienze del genere sono state portate avanti dal gruppo di progettazione urbanistica partecipata del Prof Sartore (di cui con orgoglio ho fatto parte) a San Marco di Perugia3 e a Ponte San Giovanni4, grazie alla collaborazione con il Comune di Perugia (entrambe i progetti sono in fase avanzata di realizzazione).
- La politica dovrebbe innovare di più, assumendo un ruolo quasi missionario nel proporre e sperimentare strategie che vadano controcorrente, capaci di promuovere un ritorno alle microeconomie locali, che storicamente hanno alimentato un tessuto lavorativo diffuso, solido e relazionale. Questo cambiamento richiede un profondo ripensamento delle nostre abitudini di consumo e produzione. Se da un lato siamo ormai assuefatti alla velocità con cui soddisfiamo bisogni spesso superflui, dall’altro sentiamo una fame profonda di autonomia, di manualità, di “fare con le proprie mani”. Un desiderio frustrato dalla diffusa perdita di competenze essenziali e dall’incapacità crescente di essere artefici del proprio vivere quotidiano.
Queste sono solo suggestioni e sollecitazioni. Pensare alla strategia politica, economica ed urbanistica è compito del decisore pubblico, affiancato e supportato da chi di dovere. Non è quindi l’intento di questi post dare alcuna ricetta risolutiva.
Per concludere, quando si parla di spazio pubblico bisogna pensare a qualcosa di concreto, perché esso fa parte della nostra quotidianità. L’immagine concreta di riferimento che tengo stretta parlando di spazio pubblico è legata al ricordo che ho dell’esperienza a Lisbona. Questa città, vittima di recessioni economiche e ricostruzioni successive a calamità naturali, ha scelto il criterio della bellezza e della sapienza tecnica per risorgere. Oggi le sue strade sono costellate di situazioni impreviste in cui poter sostare. Sono tantissime le piazze che si incontrano per strada, i belvedere, i percorsi, le aree di sosta. È piacevole fermarsi, interessante camminare. È spazio pubblico.
Siamo preoccupati per l’indirizzo che sta prendendo la nostra società. Il cuore dell’uomo ha bisogno di più, di quella bellezza che è data dallo stare insieme in modo spontaneo e libero, dalla cultura, dai valori e dalla bellezza dello spazio che accoglie ciò (proprio per quello che si diceva nel primo post). È la bruttezza di ciò con cui ci relazioniamo che ci impoverisce, e abituandoci a questo ci disillude che si possa sperare in qualcosa di più, ci porta alla rassegnazione.
Abbiamo bisogno di relazioni e di spazi belli. È questo che con la rubrica spazio pubblico si è provato a dimostrare, ed è questo il motivo per cui esiste “interstizi”. Continuiamo a parlarne e a cercare esperienze che vadano in questa direzione.
Note
-
De Carlo G., L’architettura della partecipazione, cit., p. 74. ↩
-
Bianchetti C., Spazi che contano, cit., p. 113. ↩
-
https://corrieredellumbria.it/news/attualita/8226/perugia-alberi-e-aree-pedonali-nuovi-interventi-nel-quartiere-di-san-marco-da-oltre-700-mila-euro.html e https://www.umbriajournal.com/inevidenza/san-marco-a-perugia-inaugurata-la-nuova-viabilita-511834/ ↩
-
https://www.cronacheumbre.it/2022/07/10/la-svolta-pop-di-ponte-san-giovanni/ ↩